Sensibilità, introversione e disagio psichico
di Nicola Ghezzani
Linee storiche di un’idea
Nel 2002, nel libro Volersi male1, misi per la prima volta in forma compiuta un’intuizione che si rivelò poi fondamentale per la mia attività sia teorica che clinica. Ne avevo già accennato in alcuni scritti precedenti, ma in quel libro l’esposizione della tesi raggiunse una maggiore compiutezza.
In questo libro descrissi, nella forma estesa e organica di un saggio, questa semplice idea:l’iperdotazione psichica (emotiva, empatica, cognitiva, riflessiva) è una delle cause principali del disagio psichico. Si trattava di una tesi paradossale perché coglieva nella ricchezza della vita psichica nonché un dono, suscettibile di dar luogo a vite ricche e generose, una maledizione tale da comportare incomprensioni ed infelicità permanenti.
Questo concetto l’avevo già espresso con chiarezza in un testo del 2000, rimasto purtroppo inedito (e pubblicato, molti anni dopo, in PDF, sul mio sito personale). Il testo si intitolava Il delirio e l’armonia del mondo e portava come sottotitolo: Il significato sociobiologico della psicosi. La storia di questo testo – un vero e proprio libro, per quanto di dimensioni minori – è complessa, ma vale la pena farvi cenno.
Nel 2000 avevo pubblicato il mio primo libro di un certo successo, Uscire dal panico, e l’amico e collega Luigi Anepeta ne era rimasto colpito. A partire dai miei ventuno anni in un momento di seria difficoltà, Luigi mi aveva accolto come paziente e formato come psicoterapeuta; più tardi, quand’ero ancora un giovane e sconosciuto laureato in Psicologia, mi aveva aiutato ad avviare l’attività professionale, offrendomi di lavorare gratis nel suo studio. Consapevole del debito di riconoscenza che avevo nei suoi confronti mi chiese di scrivere un libro insieme e di presentarlo al mio editore. Da tanti anni lavorava sodo ai suoi scritti senza ottenere il riscontro pubblico che avrebbe meritato: aveva dunque bisogno del mio aiuto.
Lo invitati a pranzo e lui si presentò a casa con un regalo per mio figlio e un dischetto per me, con al suo interno un file già redatto. Si trattava di un lungo elaborato sulla schizofrenia. Me lo consegnò pregandomi di scrivere un libro a quattro mani con lui: io avrei dovuto comporre un testo che lo compendiasse, quindi, avrei dovuto ottenere dal mio editore la pubblicazione dei due lavori in un unico volume. Non ebbi alcuna esitazione. Mi dispiaceva che non avesse ancora ottenuto il riconoscimento pubblico che meritava. Naturalmente mi era ben chiaro che un libro sulla schizofrenia sarebbe stato un insuccesso – come poi fu –; ma la sua richiesta di aiuto era intensa e diretta, sicché non volli sottrarmi.
Cominciai a scrivere e ci scambiammo idee per alcuni mesi, al fine di migliorare e integrare i nostri lavori. Gli inviai il file definitivo del mio saggio e lui lo lesse con calma. Completò anche il suo. Alla fine, raccolsi tutto in un unico file e lo inviai al mio editore. Il testo redatto da Luigi risultò molto più lungo del mio e il mio referente editoriale me lo fece notare. Non avrebbe avuto senso, mi disse, pubblicare un libro sulla schizofrenia di oltre trecento pagine, anche perché il lavoro di Anepeta era già abbastanza corposo e possedeva una forma compiuta tale da non necessitare l’affiancamento di un secondo elaborato. A quel punto, decisi di lasciare campo libero al mio vecchio analista. Favorii la sua pubblicazione, che fu compendiata da qualche nota (posta in appendice) estrapolata dal mio testo. In fondo, pensai, il mio lavoro avrebbe potuto essere pubblicato, un giorno, come volume autonomo. Se ciò non accadde fu perché i miei interessi furono presto attratti da altri temi.
Questa breve annotazione storica serve ad illustrare al lettore i motivi della presenza nelle due opere, la mia e quella di Luigi Anepeta, di temi e terminologia strettamente affini. La mia riflessione personale e quella di Luigi sono sempre state strettamente interconnesse. Alla data del 2001 questa intima sinergia avrebbe dovuto finalmente esplicitarsi in una pubblicazione comune; purtroppo ciò non avvenne.
Al comune interesse nel sistema teorico si aggiunse presto il tema delle iperdotazioni e dell’introversione che fa ancora da sfondo a molte delle nostre pagine. La nostra riflessione è andata a tal punto di pari passo che sia il suo saggio più noto, Timido, docile, ardente2, pubblicato per la prima volta col titolo Sei introverso? (2005), in cui egli fa una sintesi delle sue ricerche sull’introversione, sia la successiva fondazione della LIDI (Lega Italiana per la tutela dei Diritti degli Introversi) suscitano in me sentimenti di familiarità e un pieno riconoscimento intellettuale.
All’idea centrale, formulata in sinergia, ciascuno ha in seguito portato i propri contributi, come avviene in ogni comunità scientifica.
L’idea centrale
I miei due testi (Il delirio e l’armonia del mondo, del 2000, e Volersi male, del 2002) sono l’uno con l’altro strettamente interconnessi. Nel primo enuncio in forma sintetica ciò che nel secondo è sviluppato nel corso di diversi capitoli. In sintesi vi affermo che il disagio psichico ha due fonti principali: il maltrattamento precoce intenzionale e il maltrattamento educativo non intenzionale su soggetti iperdotati, non di rado ipersensibili.
La mia tesi non voleva in alcun modo suggerire che ogni disagiato psichico sia un iperdotato mentale. Il disagio psichico nasce da molte e diverse condizioni di partenza, fra cui non di rado un ambiente anormale, carente o persecutorio. Non di meno, e in misura anche maggiore, una delle più frequenti condizioni che portano a un disagio psichico è una iperdotazione emotiva e/o intellettiva mal compresa e mal gestita da un ambiente inadeguato.
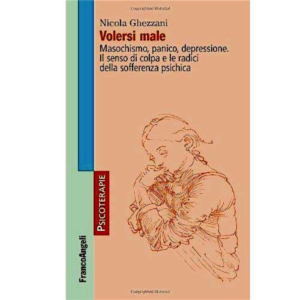
Quindi:
1) non ogni disagiato psichico è un iperdotato mentale
2) e non ogni iperdotato mentale è un disagiato psichico;
3) e tuttavia con buona dose di realismo si può affermare che ogni iperdotato mentale sperimenta nel corso della vita un certo rischio di disadattarsi rispetto all’ambiente e quindi di ammalare nella psiche.
Sensibilità e introversione
Innanzitutto, anche in Il delirio e l’armonia del mondo facevo una breve storia del concetto e ricordavo che, nel mio primo libro edito, Passioni psicotiche3 , avevo già avanzato l’idea delle iperdotazioni in una forma ancora molto sintetica. Rievocando quel libro, scrivevo:
In Passioni psicotiche ponevo, in forma problematica, questa precisa esigenza teorica:
Riteniamo inevitabile la definizione di una teoria del disagio psichico […] che spieghi che essendo ciascun individuo una unità psicosomatica radicalmente inserita nel mondo in un complesso equilibrio ecologico, le trasformazioni che noi osserviamo in sede psicologica e biologica negli individui disagiati possono essere intese quali tentativi autonomi di riequilibramento di un sistema gravemente squilibrato in qualche suo punto (Ghezzani, 1998, p.21).
Affermazione cui facevo seguire questa ipotesi:
Il disagio psichico è un tentativo cieco, cioè alienato, di riequilibrare uno squilibrio prodotto dall’ambiente, squilibrio che ha scisso e conflittualizzato livelli profondi della personalità. Non può non tornare alla mente, a questo punto, la lezione langhiana: «Può darsi che la nostra stessa società soffra di disfunzioni biologiche e che certe forme di alienazione schizofrenica dalla alienazione della società abbiano una funzione socio-biologica che non abbiamo saputo riconoscere (Laing, 1967, p.120, il corsivo è mio)».

R. D. Laing
La cultura antipsichiatrica, dunque, qui nelle lucide parole di Ronald David Laing, è stata la prima a sollecitare in forma intuitiva, filosofica e prescientifica, la nozione di una funzione sociobiologica del disagio psichico e delle sensibilità in esso implicite. E a sollecitare inoltre non solo azioni di tutela morale o politica dei disagiati, ma la nascita di una scienza in grado di spiegare il loro mistero: il mistero di doti psichiche superiori alla media in menti franate nei sintomi delle nevrosi o delle psicosi.
Dunque, sin dal 1998 auspicavo la riforma della scienza psichiatrica in questa direzione: «la nascita di una scienza in grado di spiegare il loro mistero: il mistero di doti psichiche superiori alla media in menti franate nei sintomi delle nevrosi o delle psicosi». E ponevo un postulato fondamentale: sia la sindrome psicopatologica che il sintomo al suo interno avrebbero dovuto trovare una spiegazione nel contesto di sistemi di autoregolazione sociobiologica.
La mia idea era che mentre la psichiatria alternativa italiana (di Basaglia e i suoi seguaci) si fosse espressa soprattutto in un’azione politica intesa a chiudere i manicomi e a restituire il disagio al territorio, quella inglese, in particolare grazie al genio di Ronald D. Laing, avesse espresso l’idea che chi ammala nella psiche sia un individuo con doti empatiche eccedenti rispetto a quelle del sistema familiare e sociale in cui vive e che queste doti siano intese a bilanciare squilibri insiti nel sistema.
Fin qui Passioni psicotiche, del 1998. Ecco ora come articolavo, con ben altra ampiezza, questo stesso concetto nel 2000, in Il delirio e l’armonia del mondo:
Abbiamo sin qui presentato due ipotesi correlate: la prima è sul carattere genetico (la sensibilità) che distingue la quota di popolazione a rischio psicopatologico; la seconda è sul significato sociobiologico di questo carattere.
Le osservazioni sulla psicopatologia e particolarmente sulla schizofrenia sembrano confermare il postulato assiomatico della psichiatria biologica dell’esistenza di una predisposizione genetica alla psicopatologia, assioma corroborato dall’evidenza di alcuni dati: innanzitutto la presenza effettiva dei cosiddetti “fattori predisponenti”; quindi, la regolare distribuzione statistica nella popolazione globale.
Tali osservazioni, tuttavia, lungi dal risultare per noi scoraggianti, costituiscono proprio quanto ci ha portati a formulare la nostra ipotesi teoretica centrale, un’ipotesi psicosociogenetica: il carattere genetico differenziale di quella quota di soggetti che, in casi-limite, giunge alla psicopatologia, è la sensibilità.
In una sua vecchia intervista, R. D. Laing dice a un certo punto:
Ho ricevuto da [alcuni scienziati] lettere dove dicevano che erano completamente d’accordo con me: che […] non esisteva alcuna vera ragione che autorizzasse la psichiatria a sostenere una relazione genetica per la schizofrenia [e, di conseguenza, per tutti gli altri disturbi psichici di minor gravità]. Badi bene, anche se esistesse, ciò non vorrebbe dire altro che esiste un certo stile psicologico che è odiato e boicottato dalla nostra società (1995, p. 374).
Ebbene, questo “stile psicologico” cui si riferisce Laing è, nella nostra ipotesi, il carattere genetico differenziale costituito dalla sensibilità.
La seconda ipotesi da noi avanzata è che la sensibilità (e in particolare quella a orientamento riflessivo, ossia introverso) ha una precisa funzione sociobiologica: la funzione di ottimizzare, armonizzandole, le interazioni umane. Coerentemente a ciò, quando unita alla dotazione intellettiva, la sensibilità ha la funzione sociobiologica di elaborare le strutture segniche, di significato, che guidano l’evoluzione della cultura, cioè di quella “seconda natura” in cui procede l’evoluzione dell’uomo. Dunque, la sensibilità assolve alla funzione di ottimizzare le interazioni umane in due modi: da una parte armonizzandole affettivamente; dall’altra trasformando la loro struttura segnica – i sistemi di valori – qualora essa disfunzioni. Salta subito all’occhio che queste due forme di funzionamento proprie della sensibilità possono facilmente entrare in reciproca contraddizione. […]
La sociobiologia della sensibilità riflessiva rivela che la specie produce una quota di soggetti maggiormente predisposti di altri a sentire, intuire, pensare la fonte dei significati (l’Altro) al livello della percezione delle relazioni sistemiche e dell’armonia globale. Perché? La risposta che si può ora fornire penso sia questa: allo scopo di tener viva la riflessione sui significati, cioè sulla cultura, la seconda natura dell’uomo; dunque allo scopo di tener viva la riflessione sulle potenzialità autopoietiche della specie. Di fatto, attraverso l’evoluzione culturale la specie umana prosegue il suo adattamento a se stessa (alle sue complesse caratteristiche neurobiologiche) e al mondo naturale.
La sensibilità, assieme all’intelligenza cognitiva e logico-operativa, è lo strumento elettivo di questo adattamento.
In tal senso, data la complessità crescente dei sistemi umani e dato il crescente potere di intervento tecnologico della specie su se stessa, gli individui sensibili – e fra questi gli schizofrenici – possono essere considerati le sentinelle del possibile fallimento sociobiologico, autopoietico, dell’uomo; quindi, della sua possibile estinzione.
Enunciai questo concetto nel 2000, in Il delirio e l’armonia del mondo, e lo ripresi in Volersi malenel 2002; dunque non ho alcun imbarazzo nel rivendicarne la paternità e ad assumermene la difficile responsabilità scientifica. La maggior parte di coloro che ammalano nella psiche sono i rappresentanti di una minoranza genetica di iperdotati psichici attraverso la quale la specie interagisce con la propria seconda natura: la cultura. Mi pare di essere stato il primo, almeno qui in Italia e a mia conoscenza, a formulare una simile ipotesi.
Sono altresì consapevole che nell’era di Internet l’identità dell’autore – rispecchiata e autenticata dalla “sua” idea – s’è diluita a un punto tale da non esistere più. Siamo in un’epoca nella quale situare un concetto in una precisa genealogia storica – che indichi il “luogo” (attraverso la pratica tradizionale della citazione) nel quale per la prima volta quel concetto è comparso – è divenuto una pratica ardua e quasi implausibile. Ormai un concetto nasce in un luogo per riapparire un istante dopo in altri centomila, per esservi variato in modi pensati o casuali. Le idee, con il loro potere magnetico di adesione, con la loro velocità di replicazione e la loro diffusione globale, sovrastano il singolo individuo. Sono creature mediatiche dotate di potenza propria. In un certo senso, vivono al di fuori del tempo e dello spazio tradizionali, sicché il concetto di “proprietà dell’idea” – come già quello di “diritto d’autore” – sono messi in una posizione rischiosa e di dubbio.
La paternità di un’idea può tuttavia essere rivendicata sia in base ai documenti relativi alla sua origine, sia per le sue conseguenze, di cui solo il padre reale può accettare di farsi carico. Tratteggiare le linee genealogiche di un’idea segna un destino: delinea tanto l’impulso di avvio, quanto la sua meta. La storia di un concetto diventa così progetto del suo sviluppo futuro.
Qualità psichiche a rischio psicopatologico
La sofferenza così come la conosciamo – questo è il punto focale della mia concezione – non è il prodotto di una ipo-dotazione, di una carenza genetica nella sintesi di una proteina o di un deficit di apprendimento, bensì di una iper-dotazione nell’ordine di specifiche qualità psichiche: sensibilità, empatia, intuizione, riflessività, introversione, immaginazione, intelligenza, creatività.

Lucian Freud, Self portrait with hyacinth in a pot
Fra tutte, è necessario tenere sempre presenti almeno tre delle qualità citate, che rappresentano altrettanti movimenti dialettici nel progresso verso la creazione intellettuale: la sensibilità, la riflessività, la creatività.
La sensibilità è innanzitutto la capacità somato-percettiva di tendere all’omeostasi dinamica, cioè a una stato fisiologico in cui l’equilibrio sia quieto e allo stesso tempo mobilitato da emozioni e azioni che accrescano la sicurezza vitale, quindi piacevoli. Consiste quindi di una intuizione innata dell’armonia o della disarmonia che avvertiamo nel rapporto bio-psicologico col nostro corpo e, attraverso di esso, con il mondo umano e naturale intorno noi. Essa è sia somatica che psicosomatica. Grazie alla sensibilità agli stati intracorporei stabiliamo ciò che ci fa stare bene, quindi ciò che è compatibile, complementare e armonico; estesa al mondo delle relazioni sociali, quella stessa sensibilità ci aiuta a distinguere quanto vi è in esse di buono e di cattivo.
La sensibilità, dunque, ci suggerisce, per analogia e per analisi differenziale, il “bello” e il “brutto” della vita, quindi anche il “buono” e il “cattivo”, e ciò sin dalla nascita, essendo essa una qualità inerente il soma, il corpo, il dato biologico elementare. Alcuni si sentono ben adattati al contesto in cui vivono e al modo in cui quel contesto tratta la loro esistenza psicosomatica; altri lo sono meno, o perché sono maltrattati, o perché hanno ricevuto dalla natura una dotazione di sensibilità maggiore o diversa rispetto a quella dell’ambiente con cui interagiscono.
La sensibilità è, dunque, la prima sentinella della disarmonia che può instaurarsi fra individuo dotato e ambiente: essa registra nel contesto interpersonale e valoriale discrepanze rispetto al rapporto che essa ha col benessere psicosomatico soggettivo e, qualora la disarmonia sia grave, può disporre il soggetto ad una reazione emotiva e relazionale oppositiva.
La riflessività (che possiamo altresì definire intelligenza riflessiva, già presente nel bambino piccolo) ci consente di farci un’idea soggettiva, quindi potenzialmente critica, del mondo. Le rappresentazioni mentali generate per percepire, classificare e sentire il mondo diventano oggetto di riflessione intra-soggettiva. In questo modo il mondo oggettivo diventa soggettivo e può essere sia confrontato che giudicato e manipolato. E’ sulla base dell’intelligenza riflessiva che possiamo avvertire e pensare le carenze del mondo oggettivo in cui siamo nati e viviamo.
La riflessione – ossia la visione degli “oggetti mentali”, delle idee, che abitano la nostra psiche – avviene innanzitutto nello spazio mentale intrasoggettivo. La sua possibile segregazione dalla comunicazione ha fatto sì che si pensi che essa faccia capo a una dimensione psicologica di “introversione”: un rivolgersi del soggetto a un “interno” della propria psiche. In realtà, la riflessione non è altro che una visione immaginaria – una sorta di contemplazione – degli oggetti mentali e del lavoro soggettivo effettuato su di essi.
Il concetto di introversione è stato creato da Jung all’interno della coppia di opposti che lo vede in contrapposizione con l’estroversione. La concezione junghiana assume come veri un paio di presupposti che vanno discussi.
Primo presupposto: internalità: la psiche è un “dentro” – una sorta di luogo chiuso – piuttosto che un “fuori”, cioè uno spazio oggettivo e condiviso; di conseguenza la psiche nasce “dentro” la soggettività per essere via via oggettivata, cioè portata “al di fuori”, e così comunicata.
Secondo presupposto: segregazione: ciò che non è comunicato (ossia oggettivato mediante espressione, esclamazione, parola, immagine, musica, idea, ecc.) non è comune e condiviso, quindi è segregato. Dunque l’introversione è la posizione della psiche caratterizzata dalla non condivisione e dalla segregazione dei propri valori personali.
Ora, mentre il secondo presupposto mi appare inoppugnabile: cioè che ciò che non è reso comunicato e oggettivo non è possibile sia comune, il primo presupposto mi appare discutibile. Secondo questo presupposto la psiche nasce dentro la soggettività per essere via via esteriorizzata. Dal mio punto di vista, la psiche è un “dentro” solo se supponiamo o vogliamo che essa sia nell’Io; ma è un “fuori” allorché ammettiamo di essere fruitori di un patrimonio simbolico collettivo. Se ho ragione, in quanto fruitori del mondo simbolico stratificato nei millenni, noi siamo contemplatori di una visione oggettiva. Quando percepisco il mio stomaco, lo faccio “dentro” la mia psiche, ma anche “fuori”, in quanto lo stomaco è un organo comune a tutti noi e lo percepisco grazie alla conoscenza che di esso ha fatto l’umanità nel corso dei millenni. Lo stesso vale per il patrimonio culturale collettivo: lo percepisco coi miei sensi e il mio pensiero, ma non nasce dentro di me. Basta pensare a un film: lo percepiamo coi nostri sensi e il nostro pensiero, dunque è nella nostra testa, non di meno la sua fonte di trasmissione è al di fuori.
Quindi l’intuizione di Jung dell’introversione sarebbe utilmente compendiata dalla visione hillmaniana di un mondo immaginale (un mondo di immagini della fantasia soggettiva e della tradizione mitica condivisa) e dall’idea di Bion di una rêverie: la disposizione dell’io a fluttuare in un mondo di sensazioni e immagini. Io preferisco parlare di percezione simbolica: una disposizione mentale a percepire l’inconscio collettivo o, per meglio dire, ciò che, con Jurij Lotman possiamo definire la semiosfera.
L’idea del mondo che può sortire dal pensiero riflessivo, se avvertita come pericolosa per la nostra integrità fisica o psichica, viene sottratta, negata alla comunicazione sociale, viene nascosta alla visione altrui, trasformando così la contemplazione oggettiva in una introversione.
A questo livello, si ha psicopatologia quando la propria personale attitudine a scegliere valori da contesti eterogenei o a formularne di nuovi genera una divergenza incoercibile con i valori del sistema sociale interiorizzato.

Lucian Freud, Ragazza dietro foglie
La creatività (ossia l’intelligenza astrattiva e combinatoria) è quella funzione psichica che consente all’immaginazione di generare ex novo oggetti mentali intrasoggettivi (sensazioni, sentimenti, idee). Attraverso la creatività, gli oggetti mentali diventano vivi nella misura in cui possono essere giustapposti, confrontati e ri-combinati nello spazio montale, quindi esteriorizzati e comunicati. Se questi oggetti mentali divergono dall’ordine sociale interiorizzato, possono esteriorizzarsi in azioni trasformative dell’esistente e/o in simboli di esse, cioè in opere d’ingegno condivisibili con altri.
La creatività è dunque la qualità attiva intesa a trascendere la passività contemplativa del processo introversivo. Ma in tanti casi, la sola apparizione alla coscienza di un simbolo divergente può generare angosce di squilibrio tali da doverli rimuovere nell’inconscio oppure controllare mediante sintomi.
In termini generali, l’iperdotazione è una qualità divergente che ha per oggetto l’intuizione psicosomatica e protopatica della felicità. L’individuo sensibile, riflessivo e creativo sente di esserne stato privato e avverte sentimenti specifici: l’ansia di poter perdere il diritto alla gioia e alla realizzazione di sé; il dolore depressivo della carenza e della felicità perduta; la rivendicazione rabbiosa di una sua restituzione; il sentimento di colpa per la rivendicazione stessa; il desiderio invidioso di sottrarla di nascosto a qualcun altro; l’esaltazione maniacale di possederla per magia ecc. ecc.
La sua azione nella vita può tradursi allora in una rabbia cieca e prendere le più varie direzioni, fino alla violenza impulsiva e alla crudeltà relazionale. Il senso di colpa e l’insorgenza di sintomi bloccano allora la sua reazione. Non di meno, egli avverte di averla avuta in dote (come una sorta di destino) e che coincide con la propria intrinseca e più o meno nascosta armonia psichica; quindi, che può recuperarla attraverso la salute e la condivisione.
Una visione prospettica
L’intento di questo articolo è di contrastare con ogni mezzo culturale la vieta ideologia che la sofferenza mentale sia il prodotto di una minorità biologica. A questo scopo ho messo a punto ipotesi alternative:
Punto primo: la sofferenza psichica – quando non sia indotta da semplice maltrattamento – è il prodotto di iperfunzioni psichiche quali la sensibilità, la riflessività, la creatività deviate dal loro sviluppo naturale.
Secondo punto: la corretta educazione sociale di queste doti, o la loro reintegrazione nella salute qualora siano andate incontro a un processo patologico, genera individui di elevata ricchezza morale e intellettuale, contribuendo alla migliore integrazione dell’individuo con se stesso e col mondo intorno a sé.
Terzo punto: la salute dell’individuo dotato migliora la qualità della vita affettiva e culturale degli altri, quindi sembra avere uno scopo biologico specifico. Come ho dimostrato sia in Volersi male che in La logica dell’ansia4, la specie umana, come ogni altra specie, produce variazioni genetiche. La più specifica fra le variazioni genetiche umane è costituita dagli individui con speciali doti psichiche. Questi individui possiedono più di altri l’attitudine a sentire e a immaginare l’armonia, sia su un piano affettivo-relazionale che simbolico; quindi passano almeno una parte della loro vita a fornire contributi per il miglioramento del mondo.
E dunque: perché in alcuni individui l’empatia, l’affettività, la sensibilità morale, l’intelligenza, la riflessività, la creatività raggiungono una piena maturazione, mentre in altri le stesse doti si rivelano fatali come diademi maledetti?
Questo è il nuovo e potente quesito che ho voluto porre nella mia riflessione teorica e che tutti noi, specialisti e appassionati, dovremmo porci nell’analisi delle personalità e della psicopatologia.
Umanità e Disumanità
La mia idea di una psicopatologia da iper-dotazione (che considero tuttora valida) è stata espressa nelle sue linee centrali tra la fine del secondo millennio e l’inizio del terzo. Nel frattempo, nelle nostre vite e nel nostro lavoro è intervenuto un fattore storico di enorme importanza: la globalizzazione (o mondializzazione). La globalizzazione ha portato con sé effetti sociali e psicologici che hanno reso meno visibile ciò che tra gli anni Sessanta e Novanta del secolo scorso cominciava ad apparire evidente. Il disagio psichico si è espanso a macchia d’olio, creando una certa confusione negli osservatori, come quando, aprendosi di colpo delle chiuse, una massa di acqua lutulenta viene immessa d’improvviso in un ruscello. Nella seconda metà del Novecento la società occidentale nella quale la psicoterapia era nata e aveva sviluppato le sue analisi era una società stabile e omogena. La psicopatologia da degrado sociale e da maltrattamento afferiva in genere ai servizi pubblici; sicché negli studi privati, dove la clientela apparteneva al ceto borghese mediamente colto, il dato di una iper-dotazione psichica intrinseca alla psicopatologia poteva trasparire con una certa chiarezza. La nevrosi classica da studio era appannaggio di individui con forti tensioni morali – di solito inconsce – dotati di capacità linguistiche e simboliche, di una certa introspezione e di una buona cultura.
Con la globalizzazione il quadro è stato confuso dall’irruzione di una psicopatologia da maltrattamento anche nelle classi alte e colte, psicopatologia nella quale il dilemma morale è soffocato da intense ed esplicite cariche di violenza. I fattori sociali che hanno prodotto questa mutazione sono almeno tre:
1) la disgregazione delle unità nazionali e delle economie locali ha generato un’umanità sradicata e pulviscolare, allettata – o costretta – a migrare per lavoro. La conseguenza su un piano psicologico è stata di indurre attaccamenti affettivi sempre più labili e una maggiore chiusura individualistica e autarchica.
2) Il medium comunicativo universale Internet ha indotto una superficializzazione sempre più effimera e narcisistica delle coscienze e dei rapporti: su Internet, gli stati d’animo vengono comunicati – o per meglio dire vengono “rappresentati” – a distanza, senza spostamento e contatto dei corpi, quindi senza ricchezza connotativa e senza obbligo di sincerità; per contro, i rapporti sessuali vengono programmati e consumati con facilità mediante l’utilizzo di appositi social; l’amicizia, la solidarietà, l’appartenenza il confronto dialettico sono sostituiti da collegamenti virtuali, quindi da simulacri immaginari. Allo stesso tempo si sono rese di facile fruizione trasgressioni – come la prostituzione, pornografia, il gioco d’azzardo, il videogioco – che un tempo o non esistevano o erano limitate dalla difficoltà della fruizione nel mondo reale.
3) Infine, immense masse migratorie di popoli privi di attitudini culturali alla riflessione e all’empatia e vieppiù disumanizzate dallo stato di criminalità endemico nei loro paesi, dall’espatrio e dal miraggio consumistico, sono penetrate nel mondo occidentale. Il loro massiccio ingresso, perlopiù oscuro e incontrollato, ha violato antichi equilibri, rendendo così la psiche occidentale – soprattutto quella europea, già fiaccata dal declino economico – più inquieta, sospettosa e a sua volta anaffettiva, aggressiva e violenta.
La globalizzazione ha così prodotto famiglie disgregate in paesi depauperati e sotto attacco economico e individui sottoposti a stress da lavoro servile o competitivo o da disoccupazione, indotti a compiere trasgressioni alla portata di ognuno. L’aumento vertiginoso di personalità maltrattate e maltrattanti ha espanso la psicopatologia da maltrattamento e quindi, per converso, ha reso meno visibile quella da iper-dotazione disadattiva. Nella storia di ogni personalità affetta da un disturbo psicologico è ormai agevole individuare famiglie disfunzionali ed esperienze traumatiche, cosa che ha portato una buona parte delle psicoterapie psicodinamiche a orientarsi verso una generica psicologia del trauma. Non di meno, l’attenzione e la focalizzazione del trauma non esauriscono l’analisi della psicopatologia né sono in grado di dare fondo al potenziale terapeutico dell’intervento.
L’esistenza di traumi non cancella il dato di fatto più basilare: nel 80/90% delle personalità affette da un disagio psichico esiste un nucleo genetico differenziale che codifica una iper-dotazione da sensibilità epatica o da intelligenza differenziale. Un elevato numero di individui – lo “zoccolo duro” del disagio – continua ad ammalare perché più sensibile, empatico, riflessivo e creativo della media. Quindi, il nostro compito intellettuali e di terapeuti non è cambiato: preservare l’Umano dal Disumano e porlo non solo al centro dell’attenzione e della riflessione culturale, ma anche dell’evoluzione storica dell’umanità.
Una conclusione eloquente
Vorrei concludere questo articolo ispirato con una citazione eloquente, tratta da uno dei miei poeti preferiti, Rainer Maria Rilke. Due brani da Appunti sulla melodia delle cose5 :
XXXIX. Noi siamo come i frutti. Pendiamo in alto da pochi rami intrecciati e ci accade di sfiorare molti venti. Quel che noi possediamo è la nostra pienezza matura, il dolce succo e la bellezza. Ma la linfa che ci fortifica scorre in un unico tronco da una radice lontana che si è fatta immensa passando tra i mondi e in tutti noi. E se vogliamo testimoniare della sua potenza, ciascuno di noi dovrà disporne secondo la natura particolare della propria solitudine. E quanti più sono i solitari, tanto più grande sarà la solennità, la commozione e il potere della loro comunanza.
XL. E proprio i più soli partecipano più di ogni altro alla comunanza. Ho detto prima che della vasta melodia della vita alcuni apprendono di più, altri meno; di conseguenza, nella grande orchestra, a ciascuno spetta un dovere più o meno grande. Colui che percepisse l’intera melodia sarebbe al tempo stesso il più solo e il più partecipe della comunanza. Sentirebbe ciò che a nessuno è dato sentire e solo perché lui, nella sua compiuta pienezza, comprende quel che gli altri origliano soltanto, nel buio di uno spazio fitto di vuoti.
Bibliografia
Ghezzani N., Volersi male, FrancoAngeli, Milano, 2002.
Ghezzani N., Passioni psicotiche, Melusina, Roma, 1998.
Ghezzani N., La logica dell’ansia, FrancoAngeli, Milano, 2008.
Laing R. D. (1967), La politica dell’esperienza, Feltrinelli, Milano, 1968.
Laing R. D. (1995), Follia della normalità, Red edizioni, Como, 1998.
Rilke R. M. (1898), Appunti sulla melodia delle cose, Passigli, Firenze, 2006.
Per contattare l’autore scrivigli una mail nicola.ghezzani@email.it
o un messaggio su WhatsApp 333 999 4797
- Ghezzani N., Volersi male, FrancoAngeli, Milano, 2002.
- Anepeta L., Timido, docile, ardente, FrancoAngeli, Milano, 2005.
- Ghezzani N., Passioni psicotiche, Melusina, Roma, 1998.
- Ghezzani N., La logica dell’ansia, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- Rilke R. M. (1898), Appunti sulla melodia delle cose, Passigli, Firenze, 2006.


